seminario
per attori
LA VOCE
Un seminario dedicato
allo studio della vocalità parlata quale organo espressivo atto
a potenziare le qualità “sinfoniche” dell’attore,
sia come capacità di relazione tra il corpo e la voce, sia come
sviluppo di una “tavolozza” ampia, variegata, “orchestrale”
di strumenti sonori. La serie di esercizi si compie con un lavoro sul
testo inteso come partitura ricca e complessa, da leggere in verticale
oltre che in orizzontale, per ricercare e far suonare insieme, “sinfonicamente”,
le distinte qualità timbriche, tonali, ritmiche, dinamiche che
il testo contiene in ogni parola, in ogni sillaba, in ogni fonema.
I semi del lavoro
svilupperanno: l’equilibrio corporeo come ricerca di un centro dinamico
di bilanciamento tra terra, cielo, orizzonte e provenienza – gli
impulsi motori – la relazione con lo spazio – la relazione
con gli altri – principi dell’azione fisica – principi
del “dialogo” – il rapporto tra energia corporea ed
energia vocale – differenti tipi di respirazione – le qualità
del suono vocale: conoscenza e utilizzo dei risonatori – l’articolazione
della pronuncia – la coscienza e il controllo tonale – la
coscienza e l’utilizzo dell’accento tonico – il lavoro
sul ritmo del testo – il lavoro sulla dinamica del testo –
la musicalità della voce parlata: voce solista e voce con musica
– la voce come strumento narrativo – la glossolalia e il grammelot
– la rappresentazione figurativa della voce nello spazio: geometrie
vocali e maschere vocali – la ricerca del personaggio vocale –
il lavoro sul testo.
Nei seminari
strutturati in 6 ore di lavoro quotidiano per una durata complessiva di
almeno 36, si prevede una prima parte di training fisico e pneumofonico
di 2 ore al giorno.
_-minima:
_-partecipanti:
_-frequenza:
ogni partecipante
deve portare un bastone di legno di circa 1,10 mt. + un testo, a memoria,
in lingua madre, di circa 50 parole + un testo, a memoria, in una lingua
straniera totalmente sconosciuta, di circa 50 parole
conferenza
L'EREDITA' GIULLARESCA
L’interpretazione
è sempre un atto di conoscenza storica che varia al variare del
punto di vista dell’interprete.
Lo stesso testo cambierà a seconda del momento interpretativo.
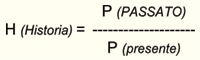
Nel riflettere
sulla natura della parola scenica, possiamo adottare, per il verbo “interpretare”,
una sorta di paradigma costituito di 3 piani che, in successione logica,
possiamo definire:
Il piano ontologico,
che si pone la domanda: “che cos’è la parola scenica?”,
a cui segue una risposta etica, secondo cui la parola scenica “è
la trasformazione della parola scritta in parola multisensoriale, creatura
vivente, nello spazio e nel tempo della performance, per mezzo
di un metabolismo organico e concettuale”. L'essenza di questa operazione
è dunque quella della metamorfosi che si compie nel passaggio da
una sostenza all'altra
Il piano teleologico,
che si chiede “a chi si dirige, qual è il fine della parola
scenica?”, a cui fa riscontro una risposta politica, che
dice “agli spettatori presenti nello stesso spazio – tempo
della performance”. “L’esecuzione è
pubblicità. È un atto di rifiuto della privatizzazione del
linguaggio che è alla base della nevrosi.” (Paul Zumthor,
“La presenza della voce”)
Il piano pragmatico,
che si domanda “come si realizza la parola scenica?”, a cui
fa seguito una risposta poetica che prevede “il lavoro interpretativo
della parola scenica, intesa come luogo d’incontro e di profonda
relazione tra corpo, voce e psiche (nel senso più ampio di 'anima').”
Diciamo risposta poietica e non tecnica, assumendo dal
verbo greco 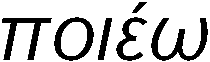 (poiéo), il significato di un fare che implica una concezione attuativa
e non "semplicemente" una messa in opera di capacità
febbrili. Quindi, quella dell’”attore sinfonico”, oltre
che una poetica, è una prassi operativa che aldilà del suddetto
rapporto “sinfonico” tra corpo e voce, mente e anima, si propone
lo sviluppo della più ampia quantità possibile di strumenti
espressivi della parola scenica. Ovvero, l’attore inteso come macchina
orchestrale contro l’attore inteso come strumento solista. Inoltre,
l’attore come antenna sensibile capace di captare dall’infinito
ogni sorta di vibrazione, da trasmettere agli altri. Ma con attore “sinfonico”
s’intende anche quel sistema complesso, ma unitario e organico,
di competenze interpretative (quindi anche autoriali), che definiscono
l’individuo scenico come una sorta di Compagnia uninominale, nella
molteplice ricchezza delle sue capacità e lo rendono responsabile
o “artefice” di un processo autonomo, in cui l’essere
umano sia l’essenza e la misura del lavoro creativo.
(poiéo), il significato di un fare che implica una concezione attuativa
e non "semplicemente" una messa in opera di capacità
febbrili. Quindi, quella dell’”attore sinfonico”, oltre
che una poetica, è una prassi operativa che aldilà del suddetto
rapporto “sinfonico” tra corpo e voce, mente e anima, si propone
lo sviluppo della più ampia quantità possibile di strumenti
espressivi della parola scenica. Ovvero, l’attore inteso come macchina
orchestrale contro l’attore inteso come strumento solista. Inoltre,
l’attore come antenna sensibile capace di captare dall’infinito
ogni sorta di vibrazione, da trasmettere agli altri. Ma con attore “sinfonico”
s’intende anche quel sistema complesso, ma unitario e organico,
di competenze interpretative (quindi anche autoriali), che definiscono
l’individuo scenico come una sorta di Compagnia uninominale, nella
molteplice ricchezza delle sue capacità e lo rendono responsabile
o “artefice” di un processo autonomo, in cui l’essere
umano sia l’essenza e la misura del lavoro creativo.
L’eredità
giullaresca gioca un ruolo fondamentale in questo percorso, per la natura
dei testi di ambito giullaresco e popolare di età medioevale, scritti
appositamente per la rappresentazione scenica, quindi intrisi di pigmento
drammaturgico e nati per far agire la parola nello spazio della comunicazione
diretta, sociale, “politica” con il pubblico. Questo principio
può e deve essere successivamente applicato a qualsiasi interpretazione
scenica rispettando le differenze (a volte profonde) fra i testi, gli
autori, gli stili e le singole forme di scrittura di qualsiasi epoca,
di qualsiasi luogo.
60 minuti
una dimostrazione
di lavoro dell'attore
sul testo letterario
“[…]
Nel significato tradizionale, la prosodia è lo studio delle regole
metriche, specialmente greco-latine. Nelle prospettive attuali della linguistica
e della semiotica i fenomeni prosodici costituiscono la base “naturale”
su cui si inseriscono le manipolazioni stilistico-strutturali del metro
e del ritmo poetici e in generale le articolazioni melodiche della scrittura
letteraria. Nella linguistica moderna i fenomeni prosodici sono il timbro
dei suoni, l’altezza, l’intensità, la durata e, soprattutto,
l’intonazione (variazione d’altezza dei suoni relativa a gruppi
sintattici o frasi) e l’accento. […]”
Con queste parole
Angelo Marchese, nel suo “Dizionario di retorica e stilistica”,
amplia il concetto di prosodia classica, ridefinendolo alla luce delle
più recenti acquisizioni concettuali della linguistica moderna.
La presente dimostrazione
di lavoro opera, a partire dai 16 versi della poesia “S. Martino”
di Giosuè Carducci, una disamina del metodo di lavoro basato sulla
partitura, detta prosodica, con cui l’interprete – autore
riscrive o soprascrive il testo originale con la propria scrittura interpretativa.
La partitura prosodica
si compone di 6 partiture sovrapposte: intenzionale, timbrica, tonale,
testuale, ritmica, dinamica, le quali conferiscono al testo una dimensione
di lettura verticale, risultante del complesso stratigrafico delle varie
indicazioni di timbro, altezza, intensità, ritmo, durata ecc. che
si attribuiscono ai distinti elementi del testo (frase, verso, parola,
sillaba o fonema).
Questa lettura
armonica, verticale, si somma alla lettura orizzontale, melodica e ne
amplia le potenzialità espressive conferendole profondità
d’indagine e maggior ricchezza di elementi connotativi.
Verso per verso,
respiro per respiro, Matteo Belli conduce chi assiste lungo il percorso
testuale, motivando ogni singola scelta interpretativa, nel tradurre la
parola letteraria in parola orale con la voce dell’attore, strumento
artigianale di trasformazione della sostanza verbale, dalla carta alla
vita della scena.
Particolarmente
approfondita è l’analisi della partitura timbrica, che presenta
l’utilizzo di 18 risonatori basilari per mezzo di filmati delle
corde vocali, mostrandone il funzionamento nei diversi stati dell’attività
fonatoria.
• esigenze
_-tecniche:
3 ore circa